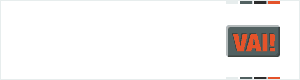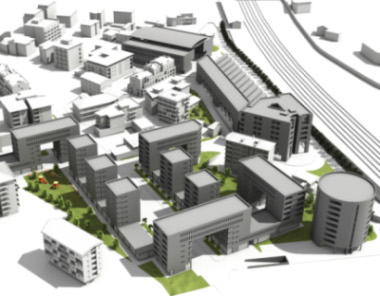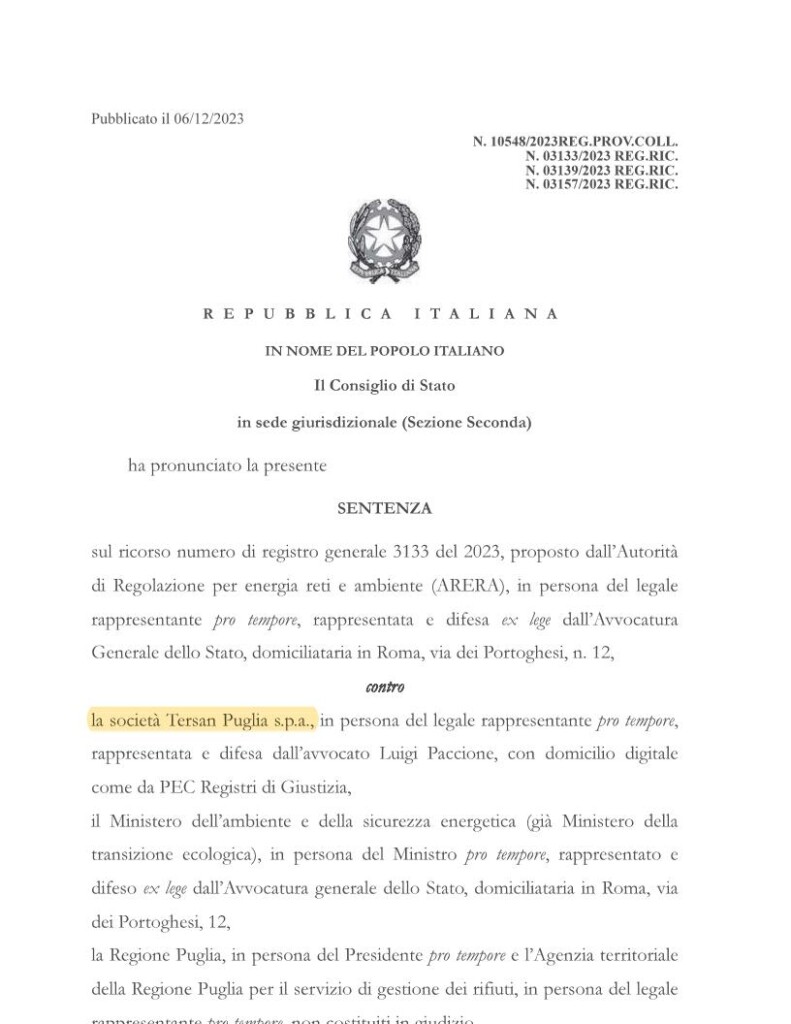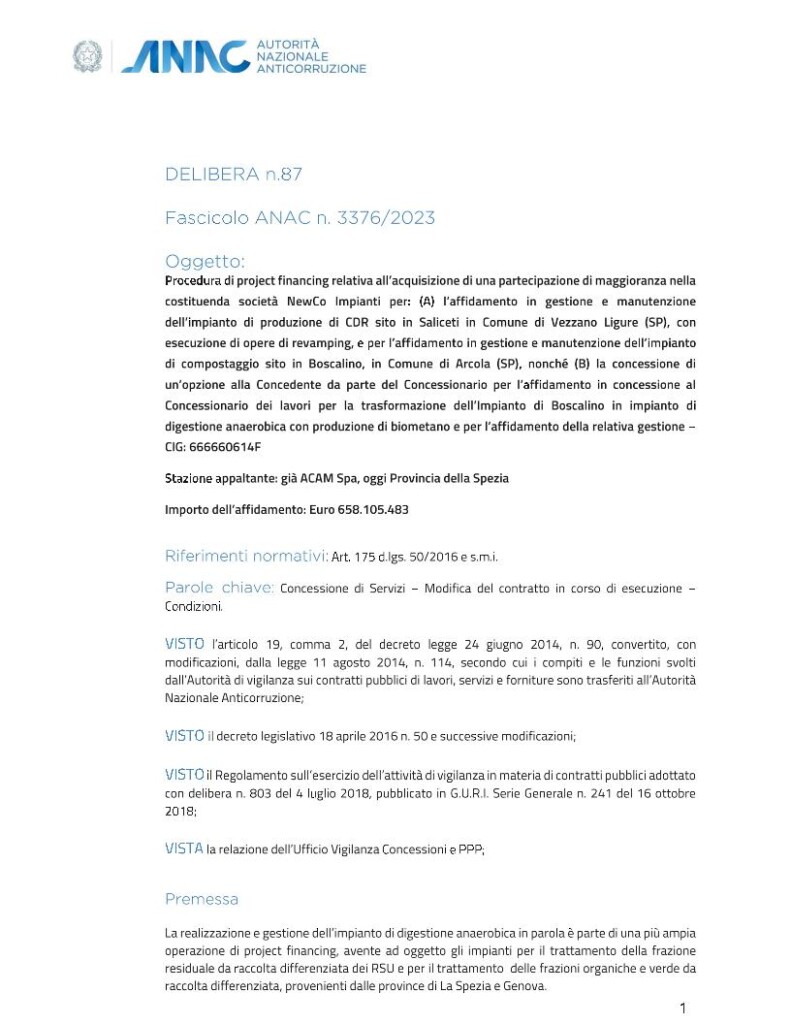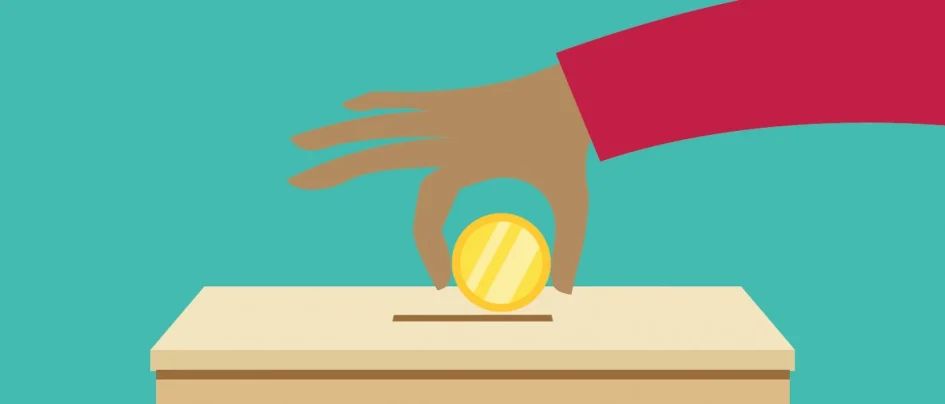L’Avvenire è il coraggio di fare Cultura

Mario Botta - Franco La Cecla (cliccare sull'immagine per visualizzare gli articoli apparsi su L'Avvenire del 3 gennaio 2010)
—————————————————-
Archistar Ma la gente non li vuole!
di Franco La Cecla
(articolo apparso su L’Avvenire il 3 gennaio)
……………………………
Bisognerebbe dedicare uno studio serio alla bipolarità schizofrenica che caratterizza oggi la cesura tra quanto le superstar dell’architettura scrivono, dichiarano, teorizzano e la loro pratica, il loro «vero mestiere»: quello di disegnare, progettare edifici, musei, quartieri, alberghi, case.
È un tema interessante.
Tutti i grandi architetti si sentono un po’ la reincarnazione di Vitruvio e Leon Battista Alberti.
Il solo fatto di essere delle superstar dell’architettura dà loro il permesso di parlare di temi più ampi, delle grandi questioni legate alla convivenza, alla globalizzazione, alla società multietnica.
Così è interessante ascoltare quello che dice in un’intervista recente Mario Botta, l’architetto svizzero italiano che ha tra l’altro firmato l’extension della Scala a Milano e innumerevoli altri progetti in tutto il mondo. Le sue parole non sono diverse da quelle di un’altra superstar – che da sempre scrive libri di teoria architettonica – come Vittorio Gregotti (progettista, tra l’altro, dello Zen di Palermo, ndr), o di una star un po’ più «modesta» come Massimiliano Fuksas. Li accomuna un disprezzo per l’espressione «archistar», una parola coniata da due geniali ricercatrici, Gabriella Lo Ricco e Silvana Micheli, in un libro pubblicato qualche anni fa da Bruno Mondadori, Lo spettacolo dell’Architettura. Tutti e tre (ma potremmo aggiungervi Zaha Hadid, o qualunque altro genio dello spettacolo mediatico dell’architettura) negano di essere delle archistar e additano al pubblico ludibrio quegli architetti che non si rendono conto, come dice Botta, che «l’architettura è ineludibile. Non si può spegnere come fosse una trasmissione che non ti piace o accantonare come un libro che ti delude». E aggiunge che gli architetti sono chiamati a lavorare «anche sul terreno della memoria, che oggi è il vero antidoto alla globalizzazione». Dovizia di citazioni da cui non deve mai mancare il riferimento a Zygmunt Bauman, alle città «liquide», una ripresa dei «non luoghi» di Marc Augè e un appello a fare fronte all’emergenza ambientale in vista di una sostenibilità dell’ambiente costruito… Insomma nulla di più politically correct delle dichiarazioni delle superstar. Come dice Botta nell’intervista: l’architettura non è lo strumento per costruire in un luogo, ma per costruire quel luogo.
Deve tener conto delle sue caratteristiche, della sua identità, del suo essere a suo modo origine.
Stranamente nessuna di queste personalità accenna mai vagamente o prende semplicemente come esempio le proprie realizzazioni.
Non se ne parla , non si racconta se sono state bene o male accolte, se sono state un fallimento o un successo. No, semplicemente esse esistono indipendentemente dai discorsi: sono l’opera, quello per cui gli architetti diventano delle superstar. Nelle interviste, nelle dichiarazioni non si parla mai dei problemi che per esempio sorgono con gli abitanti (Celerina, Boccadasse, Sarzana, ndr). Si può teorizzare la partecipazione, ma poi se un comitato cittadino protesta contro un progetto o lo rigetta, l’architetto si rifugia nelle braccia del committente, se ne lava bellamente le mani.
È quanto è avvenuto a Mario Botta con un progetto megagalattico di 200mila metri cubi di cemento attaccato al centro storico di Sarzana, fatto di cubi massicci, monumentali ed edifici a cubo che scavalcano strade .
Un comitato di 3000 abitanti (su ventimila residenti) si è opposto, si continua ad opporre, adducendo la follia di una snaturalizzazione del patrimonio storico, l’assoluta genericità del progetto che è lo stesso che Botta ha proposto a Treviso e altrove, e soprattutto la sua inutilità (Sarzana è diventata un centro che attrae per il suo fascino discreto, il Festival della Mente, l’atmosfera da piccola cittadina ligure-toscana contenuta e coerente nel suo stile). Lo stesso è avvenuto a Fuksas, contestato a Savona per un grattacielo in mare di fronte all’ultima spiaggia popolare ed amata che ne sarebbe spazzata via. Si potrebbe citare anche Pescara ed il monumento in plastica dell’archistar Toyo Ito, costato un milione e trecentomila euro ed «esploso» all’inaugurazione.
Ma una caratteristica tipica delle archistar è di non legare le parole ai fatti, di giocare di «sponda» come se fossero dei guru della società a cui tutto è permesso, perché tanto con la loro azione riqualificano il patrimonio immobiliare di un posto, ne rilanciano il brand, fanno comodo ai sindaci pigri che hanno bisogno della loro azione per dimostrare che fanno qualcosa di eclatante. Per questo a Sarzana, come a Savona, come a Pescara i cittadini, i comitati, le associazioni di abitanti non contano nulla , nonostante tutta la pubblicità che si fa alla necessità di partecipazione e di vita civile. La democrazia non fa «brand». Eppure sono anni che la partecipazione è diventata il fiore all’occhiello di molte amministrazioni, da anni a Bologna i comitati di quartieri si servono di facilitatori che fanno da tramite tra l’amministrazione e le esigenze degli abitanti, e soprattutto si è sviluppata una professionalità che si è ricavata uno spazio non indifferente nel dialogo, nella negoziazione e nella possibilità che i progetti non vengano fatti a scapito degli abitanti, ma in un processo di scambio. Ad esempio a Torino c’è un’agenzia per la partecipazione che si chiama «Avventura Urbana» e che oramai è un punto di riferimento indispensabile per ogni decisione che non voglia restare nel vuoto, ma incontrare il consenso di condomini, associazioni di strada, comitati di quartiere. «Avventura Urbana» si serve di tecniche sperimentate dall’advocacy planning in Inghilterra negli anni ’80 da personaggi come John Turner: meeting e riunioni dove il quartiere viene simbolizzato, rifatto dagli abitanti e discusso, dove ogni innesto nuovo viene compreso nel contesto e dove soprattutto si impara che la città non è cosa solo degli architetti, degli urbanisti e degli amministratori. Negli Stati Uniti esiste una commistione tra studi di architettura e agenzie di partecipazione, come ad esempio «Public Architecture». A San Francisco, un’organizzazione che sta trasformando la forma delle strade, la larghezza dei marciapiedi e detta regole alla diminuzione del traffico e all’aumento della socialità vis-a vis . Queste organizzazioni spesso stimolano forze che vengono ignorate dagli amministratori. A Pescara c’è un’agenzia guidata da Monica Giuliato, una filosofa, che si sta muovendo per fare risorgere il territorio delle imprese turistiche d’Abruzzo dal terremoto a partire dalla Confalberghi e dalla Confcommercio, attori rimasti fuori dalle logiche dirigistiche del commissariamento. Tempo fa si erano messi insieme per richiedere al Commissario un finanziamento per rilanciare il turismo. I due milioni di euro assegnati sono andati a Mediaset per un serial sull’Abruzzo e ovviamente oggi gli stessi soggetti si muovono in direzioni diverse, di coinvolgimento di comitati di giovani e di abitanti. A Milano c’è Ray Lorenzo, un architetto che si occupa da sempre di partecipazione e ha fondato «ABCittà» una organizzazione che aiuta abitanti a fondare cooperative in co- housing, gente che sceglie di andare a vivere insieme nello stesso complesso e di costruire insieme. Lorenzo è stato invitato dall’Unicef a dare dritte ai costruttori della nuova capitale del Kazakistan, Astana, riguardo allo spazio da riservare ai bambini.
Sempre Ray Lorenzo ha fondato una scuola di progettazione partecipata per rieducare architetti ed urbanisti ad un approccio più sensibile.
Dovrebbero forse andarci i nostri architetti.
———————————————————————————————————————————————-
Ma la demagogia combina disastri urbanistici
(replica di Mario Botta raccolta sull’Avvenire del 3 gennaio da Leonardo Servadio)
«L’idea architettonica può sempre essere modificata, ma l’impostazione di fondo è data non dall’architetto, bensì da fattori che riguardano il modo in cui si evolve la realtà urbana». Criticato per un edificio a torre disegnato per Sarzana, Mario Botta dice la sua: «La ‘progettazione partecipata’ non è una novità: si fece largo nel clima sessantottesco e molti professionisti impegnati vi aderirono. Notissimo il caso di Giancarlo De Carlo con le case popolari per Terni: fece scegliere il progetto ai destinatari. Fu una catastrofe urbanistica».
Perché?
«Le richieste della gente originano da quel che le è noto. Nel caso citato, gli operai cui le case erano destinate avevano in mente le cascine agricole della loro gioventù. Il tentativo di rispondere a quelle esigenze conservative si tradusse in un fallimento, perché non si può trasformare una cascina in un condominio di città. Al professionista spetta di interpretare le esigenze dell’utente e compaginarle con le tecniche costruttive attuali e con le condizioni oggettive del sito, inventando soluzioni nuove».
Quindi la progettazione partecipata non può funzionare?
«Funziona dove l’architetto è in grado di dar forma al consenso. Che però può configurarsi anche come ‘rapina’… Mi sembra che il rischio sia la demagogia: e questa conduce al fallimento. Soprattutto là dove vi siano vincoli precostituiti dal mercato o dalle scelte di piano».
Come a Sarzana?
«Proprio così: qui ci sono volumetrie che scaturiscono da indici di edificabilità decisi dall’amministrazione comunale e sulla cui base sono stati già assegnati i lotti. Si mira a ottenere un’alta densità abitativa: con edifici a torre. La decisione è già presa. Beninteso, capisco chi si oppone: sotto il profilo estetico le opinioni possono divergere. Ma per quanto mi riguarda ritengo preferibile agire su forti volumetrie in città ed evitare di invadere ulteriormente le campagna. Anche quando intervenni alla Scala di Milano mi accusavano di metter su un grattacielo che avrebbe oppresso l’edificio storico: s’è visto che il risultato è ben diverso».
Era meglio quando c’era il signore della città, unico committente?
«Ci sono sempre state tensioni, contrasti. Per un’architettura di qualità ci vuole anche discussione: purché sia autentica, competente e basata sul dialogo, non sul pregiudizio. Mi preoccupa l’ondata populistica, la contrapposizione a muso duro, la tendenza a manipolare l’emotività del momento». (L. Serv.)
———————————————————————————————————————————————-
«Consensus building» &«community design»
(intervista a Ray Lorenzo di Leonardo Servadio, su Avvenire del 3 gennaio)
 «La progettazione partecipata dovrebbe cominciare prima che siano concepiti i piani di sviluppo delle aree urbane, non quando sono già approvati: altrimenti la partecipazione si riduce al tentativo di giustificare scelte già compiute, con ben poche possibilità di influire sulla realtà». Ray Lorenzo è un ingegnere statunitense che, trasferito in Italia una trentina d’anni fa, ha cercato di importarvi la cultura del progetto condiviso. «Che richiede un approccio multidisciplinare e la capacità di dialogare. Coinvolge sociologi, psicologi, amministratori locali, architetti, urbanisti, pedagoghi, esponenti delle associazioni presenti sul territorio… Negli Usa ha radice nei town meeting che accompagnano la società sin dall’epoca della rivoluzione del 1776, e che portano la comunità a progettare il proprio spazio di vita. Questa cultura ha dato luogo alla strategia del consensus building : in cui l’accento è posto sul secondo termine, cioè sul costruire assieme, non sul primo. Vi sono corsi di laurea di community design (io l’ho frequentato a Harvard) che formano professionisti capaci per accompagnare il dialogo tra le diverse componenti della comunità, finalizzandolo al progetto dello spazio comune».
«La progettazione partecipata dovrebbe cominciare prima che siano concepiti i piani di sviluppo delle aree urbane, non quando sono già approvati: altrimenti la partecipazione si riduce al tentativo di giustificare scelte già compiute, con ben poche possibilità di influire sulla realtà». Ray Lorenzo è un ingegnere statunitense che, trasferito in Italia una trentina d’anni fa, ha cercato di importarvi la cultura del progetto condiviso. «Che richiede un approccio multidisciplinare e la capacità di dialogare. Coinvolge sociologi, psicologi, amministratori locali, architetti, urbanisti, pedagoghi, esponenti delle associazioni presenti sul territorio… Negli Usa ha radice nei town meeting che accompagnano la società sin dall’epoca della rivoluzione del 1776, e che portano la comunità a progettare il proprio spazio di vita. Questa cultura ha dato luogo alla strategia del consensus building : in cui l’accento è posto sul secondo termine, cioè sul costruire assieme, non sul primo. Vi sono corsi di laurea di community design (io l’ho frequentato a Harvard) che formano professionisti capaci per accompagnare il dialogo tra le diverse componenti della comunità, finalizzandolo al progetto dello spazio comune».
Sta parlando di qualcosa che è all’essenza della «res publica»: si racconta che nella Roma repubblicana esistesse questa cultura, ma dopo la morte dei Gracchi non sembra molto presente qui da noi…
«In effetti i contrapposti egoismi, il pensare ognuno per sé, non favoriscono la progettazione partecipata. In Germania, dove la cultura della ‘cosa pubblica’ è più diffusa, tale approccio al progetto dello spazio comune risulta più agevole. Ma anche qui in Italia qualcosa si muove in questa direzione: la cooperativa che ho fondato, ABCittà (www.abcitta.org), e che unisce architetti, pedagoghi, sociologi e altri, è stata chiamata in diverse realtà urbane.
Per esempio a Cormano (Mi) abbiamo trasformato un incrocio stradale in una piazza oggi goduta dalla popolazione.
L’essenza della progettazione partecipata sta nel senso di responsabilità che ogni singolo dovrebbe nutrire verso la propria città: a partire dagli amministratori pubblici sino all’uomo della strada».
Concretamente come avviene?
«È importante realizzare interventi su piccola scala: coinvolgere con efficacia la popolazione su megaprogetti è molto più difficile. Si riuniscono rappresentanze di cittadini, di amministratori pubblici, architetti (anche archistar, perché no?) attorno a un tavolo, e ci si confronta sugli obiettivi e sulle modalità per raggiungerli.
Ci vuole una cultura del dialogo. Se non c’è, la si può formare…. Ma non dove i piani urbanistici sono già definiti».
Leonardo Servadio
di Franco La Cecla
Bisognerebbe dedicare uno studio serio alla bipolarità schizofrenica che caratterizza oggi la cesura tra quanto le superstar dell’architettura scrivono, dichiarano, teorizzano e la loro pratica, il loro «vero mestiere»: quello di disegnare, progettare edifici, musei, quartieri, alberghi, case. È un tema interessante. Tutti i grandi architetti si sentono un po’ la reincarnazione di Vitruvio e Leon Battista Alberti. Il solo fatto di essere delle superstar dell’architettura dà loro il permesso di parlare di temi più ampi, delle grandi questioni legate alla convivenza, alla globalizzazione, alla società multietnica. Così è interessante ascoltare quello che dice in un’intervista recente Mario Botta, l’architetto svizzero italiano che ha tra l’altro firmato l’ extension della Scala a Milano e innumerevoli altri progetti in tutto il mondo. Le sue parole non sono diverse da quelle di un’altra superstar – che da sempre scrive libri di teoria architettonica – come Vittorio Gregotti, o di una star un po’ più «modesta» come Massimiliano Fuksas. Li accomuna un disprezzo per l’espressione «archistar», una parola coniata da due geniali ricercatrici, Gabriella Lo Ricco e Silvana Micheli, in un libro pubblicato qualche anni fa da Bruno Mondadori, Lo spettacolo dell’Architettura . Tutti e tre (ma potremmo aggiungervi Zaha Hadid, o qualunque altro genio dello spettacolo mediatico dell’architettura) negano di essere delle archistar e additano al pubblico ludibrio quegli architetti che non si rendono conto, come dice Botta, che «l’architettura è ineludibile. Non si può spegnere come fosse una trasmissione che non ti piace o accantonare come un libro che ti delude». E aggiunge che gli architetti sono chiamati a lavorare «anche sul terreno della memoria, che oggi è il vero antidoto alla globalizzazione». Dovizia di citazioni da cui non deve mai mancare il riferimento a Zygmunt Bauman, alle città «liquide», una ripresa dei «non luoghi» di Marc Augè e un appello a fare fronte all’emergenza ambientale in vista di una sostenibilità dell’ambiente costruito… Insomma nulla di più politically correct delle dichiarazioni delle superstar. Come dice Botta nell’intervista: l’architettura non è lo strumento per costruire in un luogo, ma per costruire quel luogo.
Deve tener conto delle sue caratteristiche, della sua identità, del suo essere a suo modo origine.
Stranamente nessuna di queste personalità accenna mai vagamente o prende semplicemente come esempio le proprie realizzazioni.
Non se ne parla , non si racconta se sono state bene o male accolte, se sono state un fallimento o un successo. No, semplicemente esse esistono indipendentemente dai discorsi: sono l’opera, quello per cui gli architetti diventano delle superstar. Nelle interviste, nelle dichiarazioni non si parla mai dei problemi che per esempio sorgono con gli abitanti. Si può teorizzare la partecipazione, ma poi se un comitato cittadino protesta contro un progetto o lo rigetta, l’architetto si rifugia nelle braccia del committente, se ne lava bellamente le mani. È quanto è avvenuto a Mario Botta con un progetto megagalattico di 200mila metri cubi di cemento attaccato al centro storico di Sarzana, fatto di cubi massicci, monumentali ed edifici a cubo che scavalcano strade. Un comitato di 3000 abitanti (su ventimila residenti) si è opposto, si continua ad opporre, adducendo la follia di una snaturalizzazione del patrimonio storico, l’assoluta genericità del progetto che è lo stesso che Botta ha proposto a Treviso e altrove, e soprattutto la sua inutilità (Sarzana è diventata un centro che attrae per il suo fascino discreto, il Festival della Mente, l’atmosfera da piccola cittadina ligure-toscana contenuta e coerente nel suo stile). Lo stesso è avvenuto a Fuksas, contestato a Savona per un grattacielo in mare di fronte all’ultima spiaggia popolare ed amata che ne sarebbe spazzata via. Si potrebbe citare anche Pescara ed il monumento in plastica dell’archistar Toyo Ito, costato un milione e trecentomila euro ed «esploso» all’inaugurazione.
Ma una caratteristica tipica delle archistar è di non legare le parole ai fatti, di giocare di «sponda» come se fossero dei guru della società a cui tutto è permesso, perché tanto con la loro azione riqualificano il patrimonio immobiliare di un posto, ne rilanciano il brand, fanno comodo ai sindaci pigri che hanno bisogno della loro azione per dimostrare che fanno qualcosa di eclatante. Per questo a Sarzana, come a Savona, come a Pescara i cittadini, i comitati, le associazioni di abitanti non contano nulla , nonostante tutta la pubblicità che si fa alla necessità di partecipazione e di vita civile. La democrazia non fa «brand». Eppure sono anni che la partecipazione è diventata il fiore all’occhiello di molte amministrazioni, da anni a Bologna i comitati di quartieri si servono di facilitatori che fanno da tramite tra l’amministrazione e le esigenze degli abitanti, e soprattutto si è sviluppata una professionalità che si è ricavata uno spazio non indifferente nel dialogo, nella negoziazione e nella possibilità che i progetti non vengano fatti a scapito degli abitanti, ma in un processo di scambio. Ad esempio a Torino c’è un’agenzia per la partecipazione che si chiama «Avventura Urbana» e che oramai è un punto di riferimento indispensabile per ogni decisione che non voglia restare nel vuoto, ma incontrare il consenso di condomini, associazioni di strada, comitati di quartiere. «Avventura Urbana» si serve di tecniche sperimentate dall’ advocacy planning
in Inghilterra negli anni ’80 da personaggi come John Turner: meeting e riunioni dove il quartiere viene simbolizzato, rifatto dagli abitanti e discusso, dove ogni innesto nuovo viene compreso nel contesto e dove soprattutto si impara che la città non è cosa solo degli architetti, degli urbanisti e degli amministratori. Negli Stati Uniti esiste una commistione tra studi di architettura e agenzie di partecipazione, come ad esempio «Public Architecture». A San Francisco, un’organizzazione che sta trasformando la forma delle strade, la larghezza dei marciapiedi e detta regole alla diminuzione del traffico e all’aumento della socialità vis-a vis . Queste organizzazioni spesso stimolano forze che vengono ignorate dagli amministratori. A Pescara c’è un’agenzia guidata da Monica Giulato, una filosofa, che si sta muovendo per fare risorgere il territorio delle imprese turistiche d’Abruzzo dal terremoto a partire dalla Confalberghi e dalla Confcommercio, attori rimasti fuori dalle logiche dirigistiche del commissariamento. Tempo fa si erano messi insieme per richiedere al Commissario un finanziamento per rilanciare il turismo. I due milioni di euro assegnati sono andati a Mediaset per un serial sull’Abruzzo e ovviamente oggi gli stessi soggetti si muovono in direzioni diverse, di coinvolgimento di comitati di giovani e di abitanti. A Milano c’è Ray Lorenzo, un architetto che si occupa da sempre di partecipazione e ha fondato «ABCittà» una organizzazione che aiuta abitanti a fondare cooperative in co- housing, gente che sceglie di andare a vivere insieme nello stesso complesso e di costruire insieme. Lorenzo è stato invitato dall’Unicef a dare dritte ai costruttori della nuova capitale del Kazakistan, Astana, riguardo allo spazio da riservare ai bambini.
Sempre Ray Lorenzo ha fondato una scuola di progettazione partecipata per rieducare architetti ed urbanisti ad un approccio più sensibile.
Dovrebbero forse andarci i nostri architetti.
Fuksas contestato per un grattacielo a Savona, Botta per il nuovo centro storico di Sarzana, il monumento di Toyo Ito che «esplode» a Pescara: sono numerosi i casi in cui la cittadinanza s’oppone a opere costose e colossali A questi guru tutto è permesso, perché fanno comodo ai sindaci pigri per dimostrare che si fa qualcosa di eclatante.
Ma un po’ ovunque nascono comitati di cittadini che chiedono di farsi coinvolgere e di giudicare i prog
Archistar Ma la gente non li vuole!
di Franco La Cecla
Bisognerebbe dedicare uno studio serio alla bipolarità schizofrenica che caratterizza oggi la cesura tra quanto le superstar dell’architettura scrivono, dichiarano, teorizzano e la loro pratica, il loro «vero mestiere»: quello di disegnare, progettare edifici, musei, quartieri, alberghi, case. È un tema interessante. Tutti i grandi architetti si sentono un po’ la reincarnazione di Vitruvio e Leon Battista Alberti. Il solo fatto di essere delle superstar dell’architettura dà loro il permesso di parlare di temi più ampi, delle grandi questioni legate alla convivenza, alla globalizzazione, alla società multietnica. Così è interessante ascoltare quello che dice in un’intervista recente Mario Botta, l’architetto svizzero italiano che ha tra l’altro firmato l’ extension della Scala a Milano e innumerevoli altri progetti in tutto il mondo. Le sue parole non sono diverse da quelle di un’altra superstar – che da sempre scrive libri di teoria architettonica – come Vittorio Gregotti, o di una star un po’ più «modesta» come Massimiliano Fuksas. Li accomuna un disprezzo per l’espressione «archistar», una parola coniata da due geniali ricercatrici, Gabriella Lo Ricco e Silvana Micheli, in un libro pubblicato qualche anni fa da Bruno Mondadori, Lo spettacolo dell’Architettura . Tutti e tre (ma potremmo aggiungervi Zaha Hadid, o qualunque altro genio dello spettacolo mediatico dell’architettura) negano di essere delle archistar e additano al pubblico ludibrio quegli architetti che non si rendono conto, come dice Botta, che «l’architettura è ineludibile. Non si può spegnere come fosse una trasmissione che non ti piace o accantonare come un libro che ti delude». E aggiunge che gli architetti sono chiamati a lavorare «anche sul terreno della memoria, che oggi è il vero antidoto alla globalizzazione». Dovizia di citazioni da cui non deve mai mancare il riferimento a Zygmunt Bauman, alle città «liquide», una ripresa dei «non luoghi» di Marc Augè e un appello a fare fronte all’emergenza ambientale in vista di una sostenibilità dell’ambiente costruito… Insomma nulla di più politically correct delle dichiarazioni delle superstar. Come dice Botta nell’intervista: l’architettura non è lo strumento per costruire in un luogo, ma per costruire quel luogo.
Deve tener conto delle sue caratteristiche, della sua identità, del suo essere a suo modo origine.
Stranamente nessuna di queste personalità accenna mai vagamente o prende semplicemente come esempio le proprie realizzazioni.
Non se ne parla , non si racconta se sono state bene o male accolte, se sono state un fallimento o un successo. No, semplicemente esse esistono indipendentemente dai discorsi: sono l’opera, quello per cui gli architetti diventano delle superstar. Nelle interviste, nelle dichiarazioni non si parla mai dei problemi che per esempio sorgono con gli abitanti. Si può teorizzare la partecipazione, ma poi se un comitato cittadino protesta contro un progetto o lo rigetta, l’architetto si rifugia nelle braccia del committente, se ne lava bellamente le mani. È quanto è avvenuto a Mario Botta con un progetto megagalattico di 200mila metri cubi di cemento attaccato al centro storico di Sarzana, fatto di cubi massicci, monumentali ed edifici a cubo che scavalcano strade. Un comitato di 3000 abitanti (su ventimila residenti) si è opposto, si continua ad opporre, adducendo la follia di una snaturalizzazione del patrimonio storico, l’assoluta genericità del progetto che è lo stesso che Botta ha proposto a Treviso e altrove, e soprattutto la sua inutilità (Sarzana è diventata un centro che attrae per il suo fascino discreto, il Festival della Mente, l’atmosfera da piccola cittadina ligure-toscana contenuta e coerente nel suo stile). Lo stesso è avvenuto a Fuksas, contestato a Savona per un grattacielo in mare di fronte all’ultima spiaggia popolare ed amata che ne sarebbe spazzata via. Si potrebbe citare anche Pescara ed il monumento in plastica dell’archistar Toyo Ito, costato un milione e trecentomila euro ed «esploso» all’inaugurazione.
Ma una caratteristica tipica delle archistar è di non legare le parole ai fatti, di giocare di «sponda» come se fossero dei guru della società a cui tutto è permesso, perché tanto con la loro azione riqualificano il patrimonio immobiliare di un posto, ne rilanciano il brand, fanno comodo ai sindaci pigri che hanno bisogno della loro azione per dimostrare che fanno qualcosa di eclatante. Per questo a Sarzana, come a Savona, come a Pescara i cittadini, i comitati, le associazioni di abitanti non contano nulla , nonostante tutta la pubblicità che si fa alla necessità di partecipazione e di vita civile. La democrazia non fa «brand». Eppure sono anni che la partecipazione è diventata il fiore all’occhiello di molte amministrazioni, da anni a Bologna i comitati di quartieri si servono di facilitatori che fanno da tramite tra l’amministrazione e le esigenze degli abitanti, e soprattutto si è sviluppata una professionalità che si è ricavata uno spazio non indifferente nel dialogo, nella negoziazione e nella possibilità che i progetti non vengano fatti a scapito degli abitanti, ma in un processo di scambio. Ad esempio a Torino c’è un’agenzia per la partecipazione che si chiama «Avventura Urbana» e che oramai è un punto di riferimento indispensabile per ogni decisione che non voglia restare nel vuoto, ma incontrare il consenso di condomini, associazioni di strada, comitati di quartiere. «Avventura Urbana» si serve di tecniche sperimentate dall’advocacy planning in Inghilterra negli anni ’80 da personaggi come John Turner: meeting e riunioni dove il quartiere viene simbolizzato, rifatto dagli abitanti e discusso, dove ogni innesto nuovo viene compreso nel contesto e dove soprattutto si impara che la città non è cosa solo degli architetti, degli urbanisti e degli amministratori. Negli Stati Uniti esiste una commistione tra studi di architettura e agenzie di partecipazione, come ad esempio «Public Architecture». A San Francisco, un’organizzazione che sta trasformando la forma delle strade, la larghezza dei marciapiedi e detta regole alla diminuzione del traffico e all’aumento della socialità vis-a vis . Queste organizzazioni spesso stimolano forze che vengono ignorate dagli amministratori. A Pescara c’è un’agenzia guidata da Monica Giulato, una filosofa, che si sta muovendo per fare risorgere il territorio delle imprese turistiche d’Abruzzo dal terremoto a partire dalla Confalberghi e dalla Confcommercio, attori rimasti fuori dalle logiche dirigistiche del commissariamento. Tempo fa si erano messi insieme per richiedere al Commissario un finanziamento per rilanciare il turismo. I due milioni di euro assegnati sono andati a Mediaset per un serial sull’Abruzzo e ovviamente oggi gli stessi soggetti si muovono in direzioni diverse, di coinvolgimento di comitati di giovani e di abitanti. A Milano c’è Ray Lorenzo, un architetto che si occupa da sempre di partecipazione e ha fondato «ABCittà» una organizzazione che aiuta abitanti a fondare cooperative in co- housing, gente che sceglie di andare a vivere insieme nello stesso complesso e di costruire insieme. Lorenzo è stato invitato dall’Unicef a dare dritte ai costruttori della nuova capitale del Kazakistan, Astana, riguardo allo spazio da riservare ai bambini.
Sempre Ray Lorenzo ha fondato una scuola di progettazione partecipata per rieducare architetti ed urbanisti ad un approccio più sensibile.
Dovrebbero forse andarci i nostri architetti.
Fuksas contestato per un grattacielo a Savona, Botta per il nuovo centro storico di Sarzana, il monumento di Toyo Ito che «esplode» a Pescara: sono numerosi i casi in cui la cittadinanza s’oppone a opere costose e colossali A questi guru tutto è permesso, perché fanno comodo ai sindaci pigri per dimostrare che si fa qualcosa di eclatante.
Ma un po’ ovunque nascono comitati di cittadini che chiedono di farsi coinvolgere e di giudicare i progetti
etti